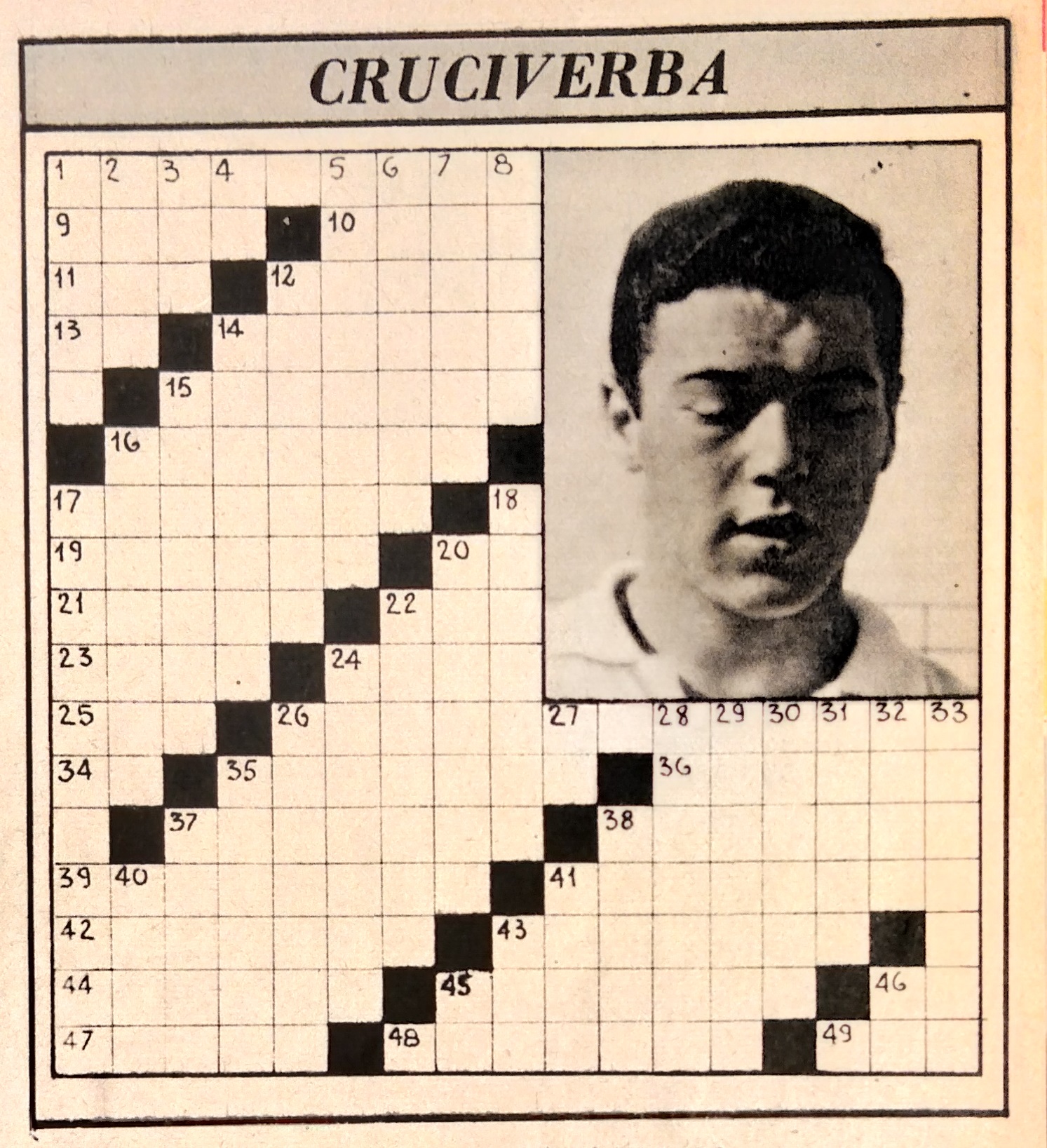La settimana scorsa ho incrociato al Circolo Canottieri Roma Nicola Pietrangeli. “Nic” è un habitué del circolo giallorosso da un mezzo secolo abbondante, e ci sta bene anche perché al CCR sono quasi tutti laziali (al confinante CC Lazio, al contrario, sono lupacchiotti, ma, si sa, non tutte le ciambelle riescono col buco). Nella realtà spicciola delle cose, ero venuto per incontrare un’altra persona, poi l’ho visto nell’atrio e la voglia di improvvisare due chiacchiere con un mito del tennis è prevalsa. Via con l’intervista registrata, dunque, e tuttavia per nulla preparata: si va a braccio.
C’è, dentro l’occasionalità dell’evento, un retrogusto elegante che non stona col personaggio. Tutto si può dire di Nicola, recordman di Coppa Davis e vincitore di due Roland Garros e due Internazionali d’Italia, meno che non sia un vero gentilhomme. Nic è nato nel 1933 ed è di madrelingua franco-russa. Cristiano-ortodosso, oltre tutto, e la leggenda vuole che pregasse nell’idioma di Tolstoj per indurre all’errore (al “peccato”) gli avversari nei punti decisivi. Nel salone del Circolo al lungotevere Flaminio, sta seduto appoggiato a un’ingombrante stampella. Un tempo maneggiava da artista racchette di legno di frassino, oggi s’industria con una stampellona che lo rimanda indietro a Enrico Toti. Gli occhi celesti slavati ricordano le tinte caramellate delle cupole di San Basilio a Mosca, o forse sono appena un riflesso velato di foschia del mare di Tunisi, dove vide la luce. Il pourparler comincia quietamente, in un meriggio di fine inverno col virus che m’impedisce di notare la mimica del suo volto. La mia prima intervista “mascherata” a un grande campione dello sport, in effetti. Trenta minuti e rotti. Il primo “servizio” lo batte lui, ed è una domanda che mi rivolge giacché sto parlando di calcetto con l’amico Remo Zenobi.
Ma tu lo sai quando è nato il calcetto? Perché tutti parlano di calcio a cinque come di uno sport degli anni ’70…
Più o meno nel 1947-48, Nicola?

Bravo! Ci sei andato vicino. Il calcetto è nato al vecchio Circolo Tennis Parioli, quello di viale Tiziano, nell’inverno 1948-49. Pioveva sempre e non potevamo giocare a tennis. Così ci siamo inventati, come si faceva a scuola con le cartelle piazzate a pali delle porte, un campo da calcio al numero 9, orrenda scelta perché ci rimbrottarono subito gli altri soci: “Come avete osato profanare in questo modo il campo centrale del Parioli?” Ma la passione per la palla era tanta e, piano piano, li convincemmo a ritagliarci un campo per il calcetto in una zona eccentrica del Circolo. All’epoca, quel gioco era conosciuto in Brasile come “futebol de salao”, calcio

da salotto, perché si giocava al chiuso. Ma noi l’inventammo “open”. Il secondo circolo in Italia a darsi al calcetto fu il TC Verbano al quartiere Trieste, il terzo il Tennis Roma a San Giovanni. Poi, negli anni ’60, arrivò “Babbo Valiani” e, ma lo dico senza cattiveria, con i suoi trucchetti cambiò il nostro modo originario, che era ancora molto vicino al calcio a undici. Infine, sono entrati in ballo i “professionisti” e tutto il fascino del gioco è sparito. Ma, al principio, noi usavamo il pallone grande e le scarpette da tennis Superga. Il fallo laterale si batteva ancora con le mani. Il vecchio Cinodromo della Rondinella stava a fianco del campo, e alcuni calciatori della Lazio, e anche della Roma, si divertivano a unirsi alle partitelle. Ricordo che noi del Parioli avevamo come soci il portiere della nazionale Giuseppe Moro, poi c’era Gunnar Nordahl, il centrattacco del Milan che nel 1956 passò alla Roma, altri tre o quattro della Serie A e Mario David, pure lui un difensore della nazionale. Ho ancora davanti agli occhi il trafiletto del Corriere dello Sport: «David infortunato non potrà partecipare all’allenamento» … e invece veniva a giocare con noi! Ma qualche cosa quei nomi noti della pedata la sbagliavano: si divertivano a tirare da metà campo e i portieri avevano gioco facile. Gli arbitri, pure, abituati al campo da cento metri, interpretavano male i movimenti lasciando correre il gioco pesante. Io li criticavo e loro non capivano che anche una leggera spintarella, nel calcetto, manda all’aria l’azione.
Nicola, anche io ho un ricordo del calcetto d’antan, ma relativo ai primi anni ’80. Un giorno, vedendo una partita a fianco di Luigi Giuliano, l’ex capitano della Roma, gli chiesi un parere e lui mi disse che non si trattava di niente altro che di una “castrazione del calcio”. Tu che ne pensi?

Allora, quando il “bisonte” Nordahl divenne allenatore della Roma, li fece giocare tutti a calcetto. Questo perchè

il contatto è immediato e ripetuto, sei costretto a sbarazzarti della palla velocemente e devi imparare a tirare preciso piuttosto che forte. Oggi il calcio a cinque lo definirei il “trionfo delle pippe”: proprio come nel padel, pensano di giocare bene e invece…
Qui al Canottieri Roma abbiamo organizzato sfide con squadre composte da calciatori professionisti e li abbiamo battuti.
Ovviamente, ho visto “calcettare” magnificamente Garrincha, D’Amico, Bruno Giordano. Vincenzino, con le sue finte estrose, mi metteva letteralmente a sedere. Bruno non lo fermavi e Garrincha era una meraviglia artistica.
Senti, avendo scritto la biografia di Fulvio Bernardini, so che nel 1945 o giù di lì il “Dottore” aveva inventato un “calciovolo”, allo scomparso sferisterio a San Giovanni. Ne hai mai sentito parlare?
Caro Marco, Fulvio, quand’era l’allenatore della Sampdoria, sceglieva i giocatori che sapevano destreggiarsi con la racchetta. Per conto mio, da capitano della squadra azzurra facevo allenare Panatta, Bertolucci e Zugarelli a calciovolo con una palletta da tennis. Io ero bravino, più di loro, e d’altronde nasco calciatore.
Detto in confidenza, se potessi riportare indietro le lancette dell’orologio, sceglieresti di diventare un campione di tennis oppure un asso del pallone?

Il tennis. E lo sai perché? A quell’epoca, non giravano molti soldi né nel calcio né nel tennis. Però, almeno nel tennis c’erano i viaggi. La Lazio, quando militavo nelle giovanili, mi avrebbe dato in prestito alla Viterbese. Ma con un Ternana-Viterbese che avrei fatto? Sarei andato al Terminillo, al massimo. Invece, col tennis, ho viaggiato i sette mari e frequentato un ambiente radicalmente diverso da quello del calcio.
Devi sapere che, negli anni ’50, il tennis era ancora uno sport da “circolo”, seppure agonisticamente non più aperto solo ai ricchi. Ad esempio, il mio storico compagno di doppio Sirola, col quale giunsi in finale a Wimbledon perdendo da Hoad e Rosewall, veniva da una famiglia di umili condizioni. Orlando era di Fiume, un gigante di due metri come Carnera, e di mestiere scaricava i sacchi di grano al mulino alle cinque del mattino.
Un altro tennista fiumano dei miei tempi, Gianni Cucelli, arrivò al suo primo circolo capitolino stremato dalla fame e subito gli diedero da mangiare qualcosa. Voglio dire: erano finiti da un pezzo i tempi del barone von Cramm o della Susanna Lenglen, che si nutriva di zollette di zucchero intrise di cognac tra un game e l’altro.
Nicola, per un caso ieri mi sono imbattuto in un vecchio articolo di una rivista milanese che diceva, pressappoco: “Il giovane romanino Pietrangeli ha un’ottima impostazione, ha talento ma gli manca la grinta, non uccide l’avversario”.

Ma, sembra brutto dirlo, oggi la differenza del premio cambierebbe la mia prospettiva. Oggi, per qualche milione di euro, ti ammazzo. Federer ha guadagnato un miliardo, Sinner già un paio di milioni. Io, in tutta la carriera, avrò raccolto centomila euro. L’Open di Parigi attuale vale due milioni e sei, ma quando lo vinsi mi consegnarono un assegno da 150 dollari! E sono approdato due volte in semifinale a Wimbledon!! Ora, non sta a me dirlo ma, analizzando i risultati, non ci piove che sono io il tennista italiano più forte di sempre. E ti dico di più: Panatta, l’amico Adriano, ha diciassette anni meno di me. Le ultime due volte che ho giocato contro di lui, nel 1971 se non erro, ho perso 6-4 al quinto. Avevo 38 anni suonati e lui 21. Tra l’altro, mi pare che in una delle due partite stavo in vantaggio 4-1 al quinto. Ma, non fraintendermi, tutto questo è secondario. Le cifre nude e crude parlano chiaro. È incontestabile che da solo ho vinto più di tutti e tre i nostri azzurri della Davis ’76.

Però c’è una differenza: tu sei stato campione in un’epoca in cui pochi giocavano a tennis, e i più bravi si davano al professionismo ed uscivano dal tuo radar…
Sì, ma non è che Adriano ha giocato contro quei professionisti che dici tu. Io li ho affrontati, ho giocato con quattro o cinque di loro. Hoad e Rosewall non li ho mai battuti. Pancho Gonzales, l’americano che rimase per otto stagioni in vetta alle classifiche, in esibizione davanti a seimila spettatori l’ho schiantato. Adriano, per fortuna sua, è venuto dopo e se l’è dovuta vedere con pochi fuoriclasse: Borg, Gerulaitis, Connors. MacEnroe. Io invece avevo il signor Rod Laver, che gli esperti considerano il più forte tennista di tutti i tempi, e poi Fraser, Rose, Emerson, Mulligan, Santana, tutti gli “erbivori” di Wimbledon. Comunque, ognuno è stato “er meglio” al tempo suo.
E allora, non posso fare a meno di domandarti: chi era il più forte tennista dei tuoi tempi?

L’australiano Hoad. E non lo dico solamente io. Se mai mi fosse stato possibile giocare la mia miglior partita, non avrei mai potuto superare Lew Hoad.
Il biondino aveva un gioco di volo inarrivabile, e anche in tutto il resto era un maestro. Serviva fortissimo, dritto e rovescio da fondo campo esemplari, la volée non ne parliamo. Ottima mobilità. E con racchette che andavano a 80 all’ora, mentre oggi servono a 250.
Io ho provato le metalliche, sul finire di carriera e già in era “Open”, e si può dire che, rispetto ad altri sport come la boxe, la tecnologia negli ultimi quarant’anni ha cambiato parecchio il gioco del tennis.

Se non sbaglio, hai vinto pure in doppio misto. Lea Pericoli, che ha scritto la tua biografia nel 2006, afferma che avevi il difetto di un’eccessiva galanteria mostrata verso le rivali.

Ho vinto il Roland Garros nel 1958. Con una inglesina di 23 o 24 anni, la Shirley Bloomer, che mi pregò di farle da compagno con un discorsetto di questo tenore: Nicola, noi britanniche siamo qui come squadra. Quando saranno conclusi i tornei individuali femminili (il misto andava in scena la seconda settimana) dovrò lasciare la città e mi dispiacerebbe molto, per via del mio fidanzato francese. Non ti preoccupare, gioca con me tanto in campo corro io… Accadde che lei perse la finale con una ungherese, mentre l’anno prima l’aveva vinta, e io fui presto eliminato sia in singolare che in doppio. Ma entrambi ci rifacemmo passando i turni del misto fino alla finale. Che vincemmo bene. Dall’altra parte della rete c’era uno di quegli australiani che qualcosa perdevano in transumanza sulla terra rossa: Bob Howe.

Ok Nic, eri un tennista appassionato e un “amateur” galante. E però, mi hanno bisbigliato all’orecchio, le carognette qui a fianco del Circolo Lazio, che hai disputato diverse edizioni della Coppa dei Canottieri nelle file del CC Roma, e che ti capitava spesso di lasciare a mezzo un impegno internazionale di tennis per correre a casa a giocare “a coppa de carcetto”. Ma come potevi fare una cosa del genere?

Su di me si raccontano un sacco di storie, e un po’ mi fa piacere. Ho fatto qualche pazzia, ma certo non per il calcetto. Io ero, e sono, un innamorato perso del calcio. Un giorno – stavo a Nizza – noi del Circolo dovevamo giocare una semifinale del Torneo Caravella Tricolore al Campo Artiglio. Nizza, e per di più il torneo del doppio, non era poi così importante, così il venerdì sera andai dal giudice arbitro e gli dissi: Guarda, domani piove. – Ma come, il tempo è splendido! – No, stai tranquillo, domani è tempesta e quindi prendo il primo aereo per Roma. Se volete, mi riaffaccio domenica mattina per la finale.
Il giorno dopo, come aveva previsto il colonnello Bernacca, sulla Costa azzurra diluviò. Il match venne rimandato. Io giocai il Caravella e mi ripresentai per la finale del tennis, che persi in coppia con Sergio Tacchini contro avversari obiettivamene più forti. Ma, in un’altra circostanza, feci proprio una… cretinata. A metà Parigi, tornai a Roma perché stava nascendo mio figlio. Ma non era neppure tanto per quello, non so cosa mi prese: feci lo scemo. E sarebbe stata la mia tripletta al Roland Garros! Nella Davis Cup, invece, nulla da fare: arrivavamo belli carichi in Australia e quei canguri benedetti ci trafiggevano senza pietà su una superficie, l’erba, sulla quale avevano consumato le loro merende fin da bambini. L’ho acciuffata da capitano, l’Insalatiera, e me la sono portata a letto, come ha scritto la Lea.
Allora, caro Nicola, tagliamo corto: calcio o tennis?
Tennis, sempre tennis. Non ho cambiato idea in questa mezzoretta. E tuttavia, serbo con piacere il ricordo di quando diciottenne

militavo nelle giovanili della Lazio. I biancazzurri erano allenati da Federico Allasio, un piemontese che aveva deciso di utilizzarci a metà settimana per un test con la prima squadra allo Stadio Torino. Allasio metteva il titolare, Sentimenti IV, in porta con noi, e il nostro Ernesto Alicicco andava con loro. Contro avevo gente come Alzani, Sentimenti V, Fuin, Puccinelli. Io ero attaccante. C’era lo stopper, Malacarne, che mi dava delle capocciate tremende. Che mal di testa…
Sorride, il buon Nic, pensando al rude Stefano Fulvio Malacarne, grossetano di Porto Santo Stefano vicino agli ottanta chili, cliente temibile nei duelli ad alta quota. E io, sinceramente, non sono del tutto convinto che il tennis sia, per lui, le “premier amour”.